Tre progetti UniSR tra i vincitori del bando Multi-round Telethon per le malattie genetiche rare

Assegnati più di 2,8 milioni di euro in Lombardia e oltre 6 milioni di euro in Italia per la ricerca sulle malattie genetiche rare, grazie alle donazioni dei cittadini
Sono 17 i progetti vincitori in Lombardia per il quarto round del bando Multi-round di Fondazione Telethon che assegna più di 2,8 milioni di euro nella Regione e 6,35 milioni di euro in Italia, raccolti grazie alle donazioni dei cittadini, che finanzieranno la ricerca sulle malattie genetiche rare.
Il bando Multi-round è stato avviato nel 2021 per permettere ai ricercatori, che desiderano richiedere i finanziamenti, di poter presentare i propri progetti in quattro occasioni nell’arco di tre anni, eventualmente rivedendoli e ripresentandoli alla luce dei commenti della commissione di esperti in caso di valutazione negativa.
Grazie a quest’ultima assegnazione, sono oltre 3.000 i progetti finanziati dalla Fondazione dalla sua nascita. La valutazione dei progetti avviene tramite il metodo della peer review sul modello delle principali agenzie internazionali di finanziamento della ricerca, come per esempio i National Institutes of Health (NIH) statunitensi. A valutare i progetti sono esperti internazionali o Italiani che lavorano all’estero che non hanno conflitti di interesse rispetto al progetto da valutare. In occasione di ogni bando, i revisori esterni che supportano la CMS possono essere individuati sia nella banca dati di Fondazione Telethon, che ad oggi ne conta circa 9000, sia coinvolti ex novo.
I progetti di UniSR finanziati dal bando
Chiara Zucchelli dell’Università Vita-Salute San Raffaele, con il suo gruppo affronterà le malattie genetiche da prioni, delle rare e letali patologie neurodegenerative che progrediscono rapidamente a causa della trasformazione della proteina prionica normale (PrPC), presente nei neuroni, in una forma dannosa (PrPSc). Attualmente non esistono trattamenti approvati. Il progetto si basa sulla precedente scoperta di una molecola, Zn(II)-BnPyP, che può combattere le malattie da prioni tramite una doppia azione: bloccare la formazione di PrPSc e diminuire i livelli di PrPC. Al momento però, l'efficacia di Zn(II)-BnPyP è limitata dalla sua difficoltà ad entrare nel cervello in quantità adeguate. Utilizzando tecniche avanzate come la spettroscopia NMR e i calcoli computazionali, il progetto consentirà di approfondire la conoscenza sul modo con cui Zn(II)-BnPyP riconosce e interagisce con PrPC. Diverse versioni di Zn(II)-BnPyP saranno analizzate per identificare i metalli e i gruppi chimici più adatti ad ottimizzare il legame con PrPC ed ottenere una forte attività anti-prionica. Studiando nel dettaglio come funziona Zn(II)-BnPyP a livello molecolare, questo progetto potrebbe portare allo sviluppo di nuove molecole con un meccanismo d'azione più potente rispetto alle molecole anti-prioniche studiate finora.
Alessandra Bragonzi dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano studierà, con il suo gruppo, la fibrosi cistica, una malattia genetica grave causata da alterazioni del gene CFTR, il quale codifica per una proteina coinvolta nella regolazione delle secrezioni di numerosi organi. Nelle persone affette, le secrezioni risultano più dense del normale, con effetti particolarmente dannosi sugli apparati respiratorio e digerente. Nei polmoni, il muco tende a ristagnare, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di infezioni batteriche e infiammazioni croniche. Attualmente, non è del tutto chiaro come si sviluppi e progredisca un’infezione polmonare che, una volta diventata cronica, non regredisce neanche con l’assunzione di terapie volte a ripristinare la funzionalità della proteina CFTR. Servono nuove conoscenze per comprendere la malattia in una prospettiva multiorgano, al fine di sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici calibrati su quella che è la fibrosi cistica oggi. Questo progetto si distingue per l’adozione di un approccio innovativo, esplorando l’interazione tra il polmone e altri organi e il loro ruolo nella progressione della malattia. Utilizzeremo un nuovo modello animale di fibrosi cistica per approfondire i meccanismi di interazione tra intestino e polmone, analizzando la correlazione tra microbiologia (studio dei microrganismi), immunologia intestinale e danno polmonare. I risultati ottenuti da questo studio potranno contribuire allo sviluppo di nuovi protocolli diagnostici e di nuove strategie terapeutiche per la fibrosi cistica.
Il gruppo guidato da Raniero Chimienti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano studierà la sindrome di Wolfram (WS1), una malattia genetica rara causata dalla mutazione del gene WFS1, responsabile della produzione della proteina wolframina, presente nella maggior parte dei tessuti umani, dove svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di molte funzioni cellulari a carico di alcuni organelli intracellulari. Esistono oltre 200 varianti del gene WFS1, responsabili della perdita completa della proteina o della produzione di una sua versione strutturalmente e funzionalmente alterata. Il malfunzionamento della wolframina causa l’alterazione di diversi processi cellulari, tra cui uno stato infiammatorio sistemico e tissutale, e uno sbilanciamento dell’equilibrio delle cellule del sistema immunitario. Nonostante la wolframina sia espressa anche dalle cellule del sistema immunitario, il suo ruolo nell’infiammazione e nelle risposte immunitarie non è stato ancora ampiamente studiato. Il progetto si propone di approfondire la conoscenza del sistema immunitario dei pazienti con sindrome di Wolfram studiando lo stato infiammatorio e le alterazioni dell’assetto genico e proteico delle componenti cellulari. I risultati ottenuti permetteranno di associare le caratteristiche osservate alla specifica mutazione del paziente. Data l’eterogeneità della malattia a livello clinico e genetico, ci si aspetta di individuare profili immunologici diversi; pertanto, si procederà alla stratificazione dei pazienti sulla base delle caratteristiche comuni per caratterizzare i meccanismi molecolari alla base delle alterazioni. Un modello murino in cui verrà riprodotto il sistema immunitario dei pazienti permetterà di verificare in vivo le alterazioni osservate, confermandone la potenzialità di diventare un bersaglio per futuri nuovi approcci terapeutici.
Ti potrebbero anche interessare

Sclerosi multipla, svolta nella ricerca: individuata una molecola che promuove la riparazione del sistema nervoso

Università Vita-Salute San Raffaele al top in Italia
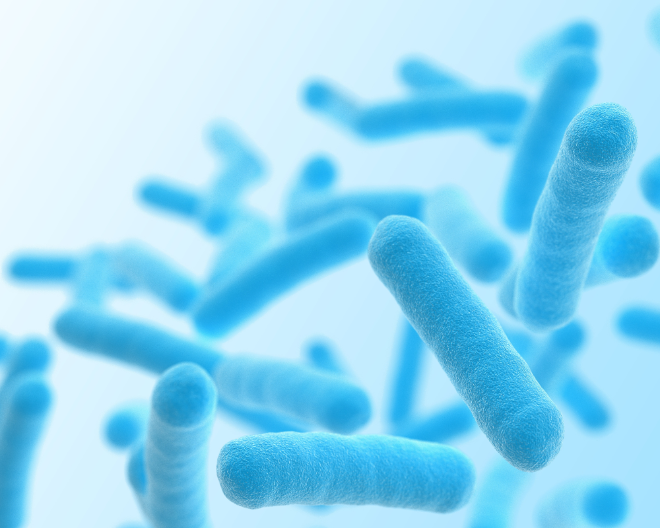
Il microbioma come alleato contro il mieloma

